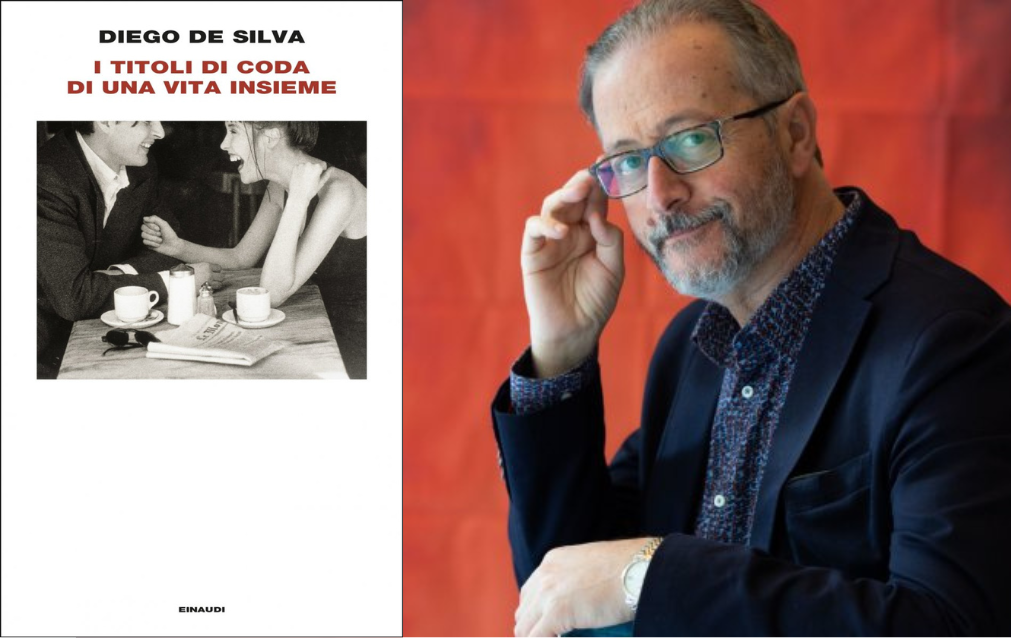
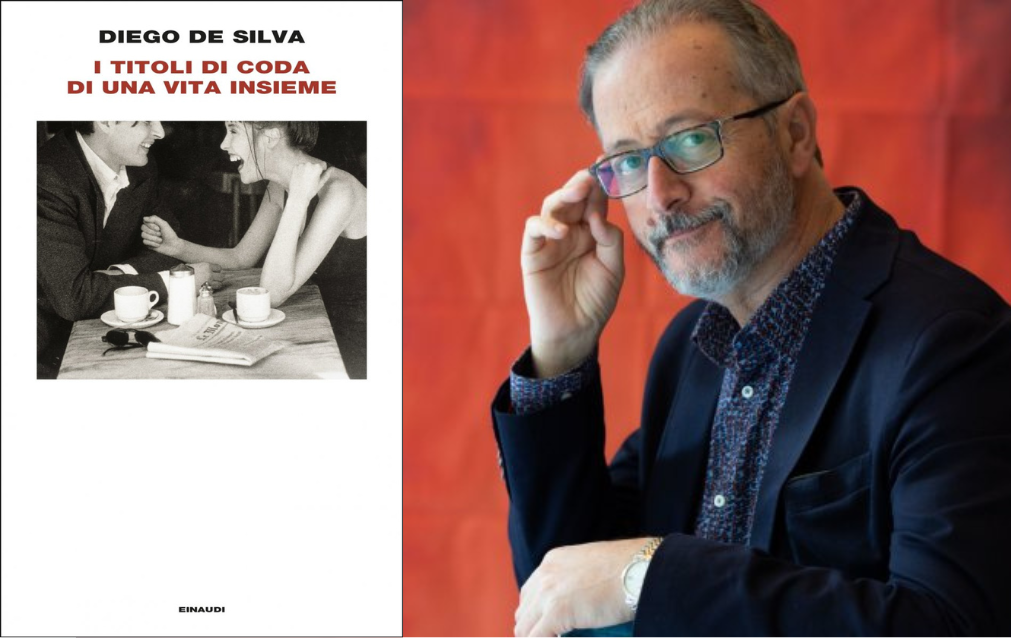
Una riflessione di Carmen Verde su “I titoli di coda di una vita insieme”, di Diego De Silva
L’amore è uno splendido uroboro
di Carmen Verde
Nemmeno proverò a dire perché ci si può innamorare de “I titoli di coda di una vita insieme”, l’ultimo romanzo di Diego De Silva, pubblicato da Einaudi. È impossibile dare una risposta al perché di un innamoramento. Ne accettiamo la natura misteriosa (e anzi, un po’ scaramanticamente, sospettiamo che farci troppe domande potrebbe essere d’intralcio, minacciare quel sentimento che sentiamo affacciarci in noi così luminoso e pieno di promesse). Ugualmente non sapremmo dire l’esatto momento in cui ci siamo innamorati: è accaduto e ci basta, sembrano dirsi tutti gli amanti. Sin dall’inizio l’amore rivela alla nostra anima che c’è una realtà superiore infinitamente più preziosa dell’irraggiungibile risposta a tutte le nostre (inutili) domande.
Pure, quando l’amore finisce, ecco che ci scopriamo meno esperti dei misteri di cui siamo stati fedeli officianti. Dimenticando che non esiste un ‘perché’, d’un tratto sentiamo il bisogno di capire il motivo della fine. E quasi ci ritroviamo a sperare che non sia uno soltanto, dato che un motivo solo non ci accontenterebbe: non può essere un motivo solo a decidere il destino di un amore. Con quanta lucidità prendiamo a interrogare – e pretendiamo di interrogare – quello stesso mistero che fin dall’inizio abbiamo accettato come tale. ‘Dobbiamo chiarire’, diciamo al nostro compagno o alla nostra compagna, come se l’amore avesse bisogno dei chiarimenti umani. Siamo all’A Dio: basta spezzare la parola perché venga fuori la sacralità del momento. Chiarite Dio, se ci riuscite.
Anche gli altri, d’un tratto, hanno con noi meno sensibilità: “Perché vi siete lasciati?”, ci sentiamo chiedere sfrontatamente da chi, fino a poco prima, mai si sarebbe permesso di chiederci “Perché state insieme?”. Ci stupiamo di non avere una risposta. Una risposta sensata capace di proteggere noi e la bellissima coppia che siamo stati (e che, a dispetto di tutto e di tutti, continuiamo a essere).
“Alice e io ci vogliamo bene. Per questo ci stiamo lasciando” dice Fosco, il protagonista del romanzo di Diego De Silva, rispondendo alla domanda interiore che lo tormenta. Parte così “I titoli di coda di una vita insieme”, ed è un incipit sapiente. Queste due brevi frasi, poste a guardia della porta, sussurrano la fine di un amore con parole che, dell’amore, condividono la natura tautologica. Mostrano di intendersi assai bene della questione uroborica del sentimento amoroso, al punto che, a pensarci, avremmo potuto usarle anche noi per rispondere all’impossibile domanda iniziale.
La storia si racconta in breve. Fosco e Alice si sono amati tanto ma, adesso, è arrivato per loro il momento di separarsi. Adesso, certo: ma chissà da quando il loro addio era in cammino, silenzioso, insidioso. “Ci rassicurerebbe trovare l’origine, lo strappo”, scrive De Silva. Ma a che serve, sembra rispondere questo romanzo con ogni sua pagina. “L’amore è discreto nel morire, non c’informa”, dice il protagonista, e aggiunge “e noi non siamo all’altezza di tanta responsabilità”.
Non lo sono nemmeno i giudici cui affidiamo le nostre separazioni. Non c’è sulla terra arbitro o giudice al quale indirizzarci per chiedere conto della fine di un amore. La parola ‘addio’ non compare nelle carte del diritto.
Intanto, però, il ricorso che sancirà la separazione legale di Fosco e Alice è già depositato in tribunale. E allora tocca trovare le parole per lasciarsi. Le parole giuste.
“I titoli di coda di una vita insieme” è un romanzo profondamente letterario, perché solamente la letteratura può esplorare questo territorio così insidioso, dove ci accorgiamo di essere, in fondo, molto soli. De Silva racconta l’amore dalla fine, senza scivolare nel sentimentalismo, con l’ampia gamma di registri narrativi cui ci ha abituato. C’è persino spazio per i momenti ridicoli che accompagnano la fine delle nostre storie, coniugali o di convivenza: come quando ci si rannicchia da una parte del letto per evitare di invadere lo spazio dell’altro, o ci si alza la mattina all’alba per non farsi trovare quando l’altro si sveglia, e si inventano mille stratagemmi per evitarsi in cinquanta metri quadri… Tutto, anche i piccoli guai quotidiani connessi alle nostre separazioni, l’autore racconta, e con lo stesso garbo con cui racconta il dolore.
Ho sentito De Silva dichiarare che “I titoli di coda di una vita insieme” è un libro triste. Sarà, ma io mi ricordo la risposta argutissima che Giuseppe Pontiggia diede una volta a una signora che gli chiedeva: “Lei Pontiggia, sempre storie di tradimenti, di infelicità… Perché non racconta di un’unione felice, senza nubi, per tutta la vita?” “Ma signora” rispose Pontiggia “non sono uno scrittore di fantascienza, io mi occupo di altre cose”. Non è uno scrittore di fantascienza De Silva, che da sempre si interroga sull’amore. In una pluralità di risonanze e variazioni tematiche, sin dal suo esordio ronza attorno all’amore, con quella splendida monotonia che caratterizza ogni vero scrittore: amori impossibili, amori che avrebbero potuto essere, amori mai nati, amori nati e finiti.
Personalmente, ho colto un’aria da “Grande Sera” in alcune pagine del romanzo e ricordo di avere anche confrontato alcuni dialoghi con quelli del romanzo di Giuseppe Pontiggia che tutti conosciamo. Non ritrovo gli appunti, peccato. C’è però una frase in cui la ‘Sera’ compare ne “I titoli di coda di una vita insieme” ed è questa: “Perché una sola cosa vogliamo, arrivati alle sette di sera della vita. Sapere che qualcuno ci ha amati”. I libri non andrebbero letti attraverso asettici prelievi di frasi, ma questo passaggio ragiona sul tempo andato e sul tempo che rimane, e a lui ci si potrà forse rivolgere quando, chiudendo il libro, ci sorgerà il dubbio che “I titoli di coda di una vita insieme” sia il romanzo degli addii, non di un solo addio, quello di Fosco e Alice.
Parlando de “I titoli di coda di una vita insieme” si finisce col parlare di dubbi, di incertezze, persino di appunti in cui si credeva di aver intravisto una risposta e che ci scompaiono sotto il naso. Il pregio più grande di questo romanzo è quello di non darci risposte. Di più: il pregio più grande di questo romanzo è quello di sapere che al mistero dell’amore che ci interroga, noi non possiamo rispondere che domandando.
Accade però al protagonista che, interrogando i suoi addii, finisca anche per interrogare il suo passato, conducendoci – di punto interrogativo in punto interrogativo – nella seconda parte del libro, che ha pagine di grande bellezza nelle quali, nonostante il paesaggio cambi e appaiano nuovi personaggi, avvertiamo che tutto canticchia lo stesso motivo. È il motivo dell’amore-rimpianto che, se nella prima parte è per l’amore coniugale, nella seconda è per il paesino dove i genitori di Fosco avevano una casa e dove, da bambino, lui ha passato lunghissime estati; la casa felice che con troppa leggerezza Fosco ha acconsentito a vendere, lasciando che a dirle addio fossero le parole fredde di un notaio
(“Ma che ne sanno i notai…”).
Ci vorrà un viaggio di cento curve per tornare a Cavaliere. Anche le pagine in quel punto si riempiono di curve: come nei tornanti si vede anche un pezzo di quello che sta dietro, così in quel viaggio in macchina torna a galla il passato. Quando Fosco e Alice arrivano a destinazione, fatalmente tutto arriva a destinazione anche tra di loro. A destino, potremmo dire.
Fosco scopre che nulla a Cavaliere è cambiato. Lì, in quel microcosmo, tutto continua “con la naturalità del perdurare delle cose”. A un certo punto gli sembrerà anche di vedere il fantasma di un suo amico rimasto bambino. Preannunciato da una nebbia forse anche interiore, finanche il favoloso fa ingresso nel romanzo. Durante una tempesta, due cani dall’aspetto minaccioso sbarrano la strada a Fosco. Un altro cane, invece, sembra riconoscerlo: è probabilmente il nipote di Bucky, il cane con cui Fosco giocava da bambino, e perciò è con tutta probabilità un Bucky III ma, nel sortilegio del tempo di Cavaliere, Fosco e Bucky III sono amici da sempre. Sono pagine, queste, in cui la ‘separazione’ si fa inevitabilmente insopportabile, contro natura, illogica. Sentiamo che le voci di Fosco e Alice, che per tutto il romanzo hanno continuato ad alternarsi di capitolo in capitolo, si fanno via via più stonate…
C’è un oggetto che sta gelosamente custodito in quella specie di Paradiso che è la casa di Cavaliere (non chiamano i poeti ‘Paradiso’ il tempo dell’infanzia?): è un tavolo di pietra, il papà di Fosco lo chiamava ‘tondo’. Fosco bambino si arrabbia, protesta: che vuol dire tondo? Non è nemmeno una figura geometrica. Ma io credo, sono convinta anzi, che Fosco adulto sappia assai bene cos’è un tondo, dalle prime parole della prima pagina di questo romanzo mostra di saperlo: un tondo è quella cosa che non si sa quando inizia e non si sa quando finisce. Come l’amore, lo splendido uroboro.


Carmen Verde intervista Diego De Silva per Casertalegge Scrittori in città


Carmen Verde, scrittrice originaria di Santa Maria Capua Vetere, da anni vive a Roma. E’ stata candidata all’edizione del 2023 del Premio Strega con il romanzo “Una minima infelicità”, edito da Neri Pozza e pubblicato in spagnolo dalla casa editrice Tránsito. Negli anni, i racconti di Carmen Verde sono stati pubblicati in antologie, saggi, riviste e plaquette di diverse case editrici. Nel 2018 è stata tra gli autori segnalati dal Premio Calvino e nel 2019 è stato pubblicato il suo libro “Tutta la vita dietro un dito” scritto con Alex Oriani.





